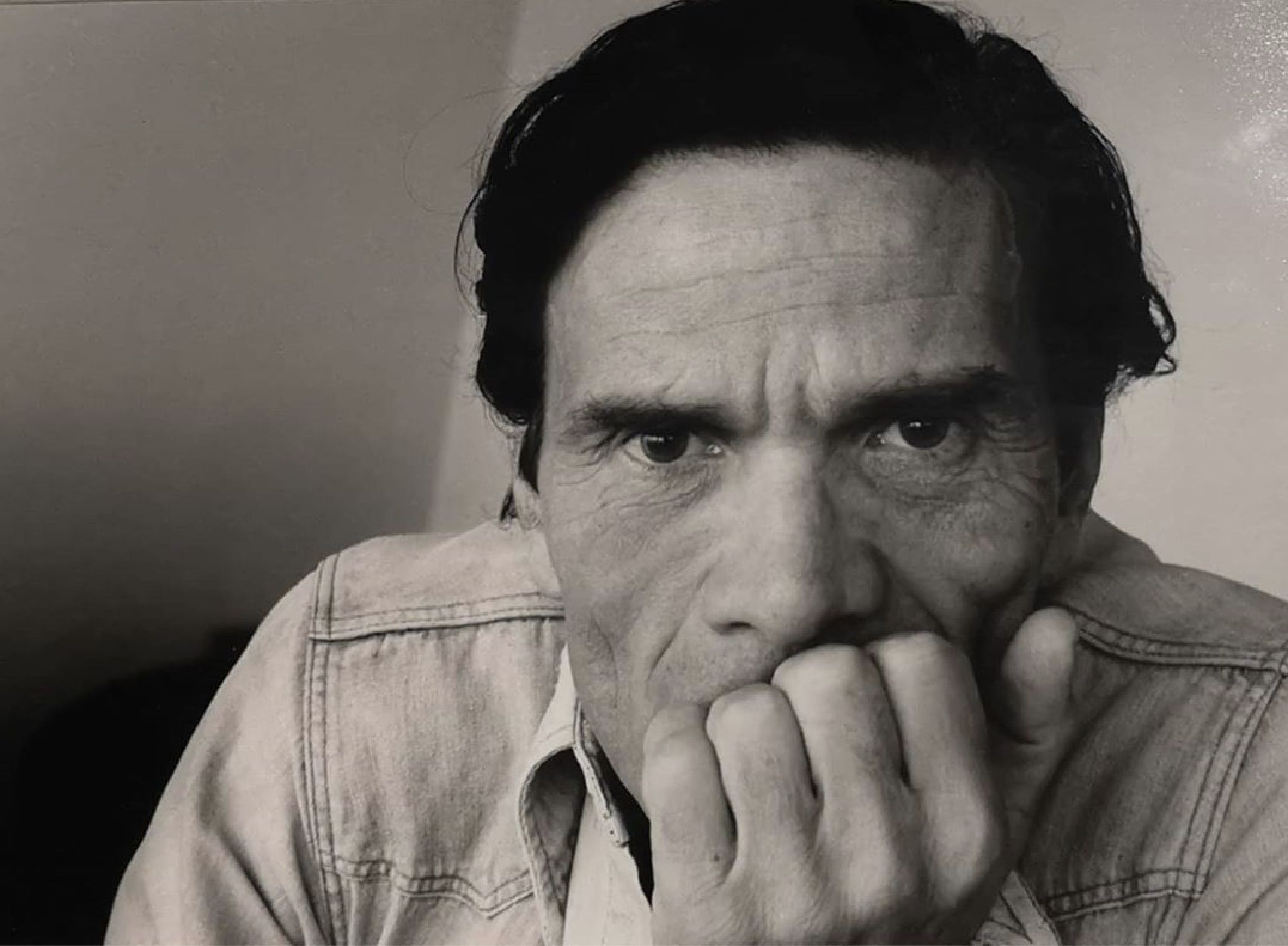- 3 Aprile 2023
- Matteo Fratarcangeli
- 0 Comments
- 630 Views
- 5 Likes
- Comuni
Forni di Sopra (UD) 8 Luglio 2023

Poco si sa delle origini più antiche di Forni, un’area probabilmente frequentata già in epoca preistorica da popolazioni nomadi, i Carno-Celti provenienti dalle pianure tra il Reno e il Danubio, mentre il dato certo è la presenza romana, attestata dal nome del villaggio capoluogo, Vico, che proviene dal latino vicus, oltre che dal ritrovamento di numerose monete risalenti a quel periodo.
Il primo nome che il Medioevo ci ha imposto è quello di “Forno”, di Sotto e di Sopra. Due villaggi che Tassilone, duca di Carlo Magno, dona all’abazia di Sesto al Reghena nel 778. La valle dell’Alto Tagliamento, il cui grande fiume corre da Ovest a Est per poi precipitare verso Lignano, protetta dai valichi di Cima Corso e Passo Mauria, era già conosciuta dai Romani che avevano edificato il loro castrum in Cuol di Ciastiel (un altro a Forni di Sotto), e poi dai Longobardi (notevoli i resti della loro necropoli in Andrazza).
Un altro castello, (restaurato e visitabile, leggi qui…), è quello di Sacuìdic risalente al 4° secolo. La sua strana posizione defilata e lontana dal centro abitato lo rende misterioso, se non altro perché serviva da zecca clandestina.
Caduto l’Impero romano, la vallata subisce le incursioni delle popolazioni barbare, tra cui un ruolo di primo piano svolgono i Longobardi. Un primo documento scritto che testimonia l’esistenza di un paese risale al 778, con la donazione del duca bavarese Tassilone di Forni e delle sue pertinenze all’abbazia di Sesto al Reghena. Nei quattro secoli successivi non si hanno notizie del villaggio, che probabilmente viveva di una magra economia legata all’agricoltura e all’allevamento, oltre che allo sfruttamento della risorsa forestale.
Quasi sicuramente Forni passa poi, nel 967, sotto il controllo del Patriarca d’Aquileia Rodoaldo, ma per avere un altro documento ufficiale che attesti la presenza di un villaggio nell’alta Valle del Tagliamento, bisogna aspettare il 1224, quando viene fissato il confine tra Forni di Sotto e Claut. Lontano dalle rotte commerciali e di scarso interesse economico, la gestione del territorio veniva lasciata a feudatari e signorotti locali, obbligati soltanto a essere fedeli e pagare dei tributi al patriarca; per il resto, erano questi personaggi a decidere, per mezzo della figura del gastaldo, delle sorti degli abitanti, creando a volte non pochi malumori.
Passano i secoli, la storia fa il suo corso, ma qui tutto sembra rimanere immutato, un angolo quasi dimenticato dove i signori locali controllano un territorio buono solo a ricevere qualche tributo, lasciando la poca popolazione a soffrire di fame, a morire di peste e malattie, a doversi arrangiare per sfamare la famiglia. È un periodo di cui si sa poco, secoli in cui la Carnia viene “scossa” solo dalle liti tra paesi vicini, dal cambio del signore locale, da questioni legate a dazi e possedimenti. Un guizzo di “notorietà” arriva solo nel XVI secolo, quando l’imperatore Massimiliano scende dalla Germania ed entra in conflitto con la Repubblica di Venezia, che aveva allora esteso il suo controllo su quasi tutta l’area del Friuli e del Veneto. È proprio uno dei signori di Forni, Girolamo Savorgnan, a opporsi con audacia all’invasore, sconfiggendolo in Cadore dopo aver valicato il Passo della Mauria in pieno inverno. In questa e nelle battaglie che seguirono, presero parte anche alcuni valorosi abitanti di “Forno”, tanto da essere lodati pubblicamente.
Passata la guerra, e “sconfitta” la peste del 1511, la vita per gli abitanti di Forni riprende uguale, ossia duro lavoro, liti continue con i villaggi vicini, fame.
Proprio nell’Anno 1511 un pellegrino transitò per Forni di Sopra, avendo come meta la locale Chiesa di San Floriano Martire ed il Santuario di Sant’Osvaldo Re e Martire di Sauris di Sotto. Egli portò l’annuncio della peste che infieriva su vastissime zone al di qua e al di la dell’Arco Alpino nonché in vaste aree d’Europa, decimando le popolazioni. I Fornesi, terrorizzati, si appellarono alla protezione Divina mediante l’intercessione della Beata Vergine Maria promettendole, come voto qualora fossero stati preservati dalla pestilenza, di dedicarle una Cappella. Ottenuto il sospirato beneficio, fedeli alla loro promessa onorarono riconoscenti il voto fatto. Nell’Anno Domini 1515, tra l’attuale Santuario della Madonna della Salute ed il Torrente Tollina costruirono un “Oratorio Campestre”, da subito chiamato “al Capitèl dala Madona dala Salût”, dove raffigurarono la Madonna della Salute con ai lati i Martiri Rocco e Sebastiano. La notizia del voto e del modesto Oratorio si sparse velocemente nelle vicine zone di Cadore, Carnia e Val Tramontina e questo divenne oggetto di numerosi pellegrini per una preghiera, un’invocazione, per chiedere una grazia.
È solo con l’inizio del XVII secolo che la vita inizia a migliorare, quando nascono le prime industrie l’agricoltura migliora e diventa più redditizia, nonostante alcune devastanti inondazioni. Caduta nel 1797 la Serenissima, il paese di Forni viene incorporato al Cadore dai francesi, che opprimo la popolazione con continui saccheggi e requisizioni, riportando gli abitanti a uno stato di grande povertà. Che per fortuna termina nel 1815 con l’annessione all’Impero austro-ungarico, che vede Forni rinconquistare una certa autonomia e ricostituirsi quel tessuto di agricoltori e piccola industria che era stato quasi annientato dal dominio francese. Dopo un cinquantennio di relativa calma, Forni e la Carnia tutta passano sotto il Regno d’Italia, migliorano le infrastrutture, e inizia una prima forma di frequentazione turistica.
Mentre la secolare emigrazione stagionale della Carnia si basava sui Cramârs, dai “Forni Savorgnani” ogni inverno scavalcando la Mauria sciamavano per l’Europa i Tessitori. Rientravano d’estate a raccogliere i prodotti di quest’arte: lino e canapa uniti poi alla lana. Tramontata nell’Ottocento questa epopea crebbero i mestieri legati alle cave e al bosco, esercitati sempre nell’emigrazione e messi in pratica nelle case del paese. Costruite con pietra squadrata che non teme terremoti e travi di conifere che reggono metri di neve. Grandi costruzioni abbellite da pregevoli portali di color nero e rosato, opera degli esperti scalpellini fornesi; caseggiati riempiti dai prodotti della terra, da famiglie allargate che vivevano a diretto contatto con fienili e stalle, fianco a fianco con l’animale principe della comunità, la mucca.
Da questo fecondo rapporto nacquero malghe e latterie sociali, salvando il Forni dalla miseria e facendo della montagna un eroico laborioso giardino di vita e ricercati orizzonti. Fu così che all’economia agricola e alle medievali locande (Alla Speranza, Alla Salute, Sacuidic) si affiancarono i primi ottocenteschi alberghi (Alla Rosa, All’Ancora).
Il Novecento sancì lo sviluppo di quella cooperazione, divenendo economia portante non solo agricola ma in tutti i settori del paese. Furono così fondate la Cooperativa di Consumo, la Cassa Rurale, due Cooperative di Lavoro, e la Cooperativa Idroelettrica (solo quest’ultima è sopravvissuta fino ai giorni nostri).
Sconvolta dagli eventi della Grande Guerra, con il fronte che passa a breve distanza sul confine con l’Austria, la Valle del Tagliamento viene invasa dalle truppe imperiali austriache dopo la disfatta di Caporetto, vivendo quasi un anno di grande miseria. Sono 70 gli eroi fornesi caduti sul fronte della prima Guerra Mondiale, molti sono i Decorati al Valor Militare per le loro gesta eroiche. La seconda Guerra Mondiale è passata quasi indenne nel comune di Forni di Sopra, le uniche violenze sulla popolazione e fatti d’armi sul territorio comunale sono stati generati da azioni partigiane. Per i valorosi fornesi che hanno combattuto sui fronti bellici invece, il tributo è stato pesante con molti caduti e dispersi. A questi eroi è dedicato il Parco delle Rimembranze eretto con 48 cippi commemorativi di fronte al cimitero di Forni di Sopra.
Terminate le ostilità, la vita a Forni di Sopra riprende con i ritmi di un tempo, con il turismo che torna ad affacciarsi su una vallata ancora incontaminata e dalla natura rigogliosa. Ma al contrario di altri luoghi sulle Alpi, qui lo sviluppo turistico non è immediato e caotico, ma si è preferito puntare sulla lentezza, sulla valorizzazione delle risorse e della cultura locale.
Nel 1954 nacque la prima Azienda di Soggiorno regionale della montagna (a Grado quella per il mare). Si affermarono vecchi e nuovi alberghi, venne asfaltata la Statale 52 “Carnica” (1956), videro la luce il cinema, il Camping, Taverna e Tavernetta, locali che hanno fatto la storia. Si costruirono “villaggi Tintai e Stinsans”. L’agricoltura ha lasciato il posto al turismo.
La disastrosa alluvione del novembre 1966 causò morti, distruzione e profonde ferite al paese. Il grande terremonto del Friuli (1976) non causò danni al paese ma tanta paura e, purtoppo, la morte di Tullio D’Andrea, Alpino in servizio di leva a Gemona.
Alla fine degli anni ’70 turismo è divenuto la stella polare di Forni di Sopra Dalle prime sciovie si passò alle seggiovie, si affermò il Varmost, si realizzarono campi da gioco, la piscina-palestra, la pista di pattinaggio, ora coperta, l’anello e lo stadio dello sci da fondo, pratica dove Forni gode di una consolidata tradizione.
Nel 1973 nascono i primi semi del futuro Parco naturale delle Dolomiti Friulane, che vedrà concretizzarsi l’area protetta nel 1990 con il Parco delle Prealpi Carniche, mentre l’istituzione ufficiale del Parco delle Dolomiti Friulane è del 1996. Un parco vissuto come un’opportunità, come fonte di reddito – economico, ma anche sociale – dagli abitanti dei paesi. Oggi Forni di Sopra e tutta l’alta Valle del Tagliamento si presentano con un territorio ricco di possibilità per un turismo attivo, dove tradizioni, natura, paesaggi e gastronomia si sposano in un felice connubio.
Negli anni 2000 il paese risponde alle nuove tendenze di un turismo della natura, del cibo tradizionale, della cultura, puntando a differenziare l’offerta, aiutando il comparto agricolo, creatore di paesaggi e pregiati prodotti locali (casere come agriturismo), riconoscendo il valore di aziende di qualità ormai affermate in campo nazionale come “Legnolandia” capofila nella filiera del legno friulano, la birra artigianale di “Foglie d’Erba” e altre che si spera crescano nel campo dell’arte e della gastronomia.
Sono sorte e consolidate realtà che valorizzino l’autenticità di ciò che esiste e di ciò che è stato. Con uno straordinario lavoro di appassionati volontari sono stati allestiti il Museo Rurale Fornese nella grande ex Latteria di Vico ed il Museo etnografico Filo dei Ricordi a Cella nella sala congressi chiamata “Ciasa dai Forness”, e la riscoperta e la promozione del fornese più conosciuto nel mondo: il grande costruttore di oboi, flauti e fagotti Giovanni Maria Anciuti.
Dal 29 giugno 2009, data della proclamazione delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità UNESCO, le frastagliate creste che sovrastano il paese sono diventate un patrimonio da gustare e condividere ogni giorno con gli ospiti della valle.
Fonte: https://www.fornidisopra.it/